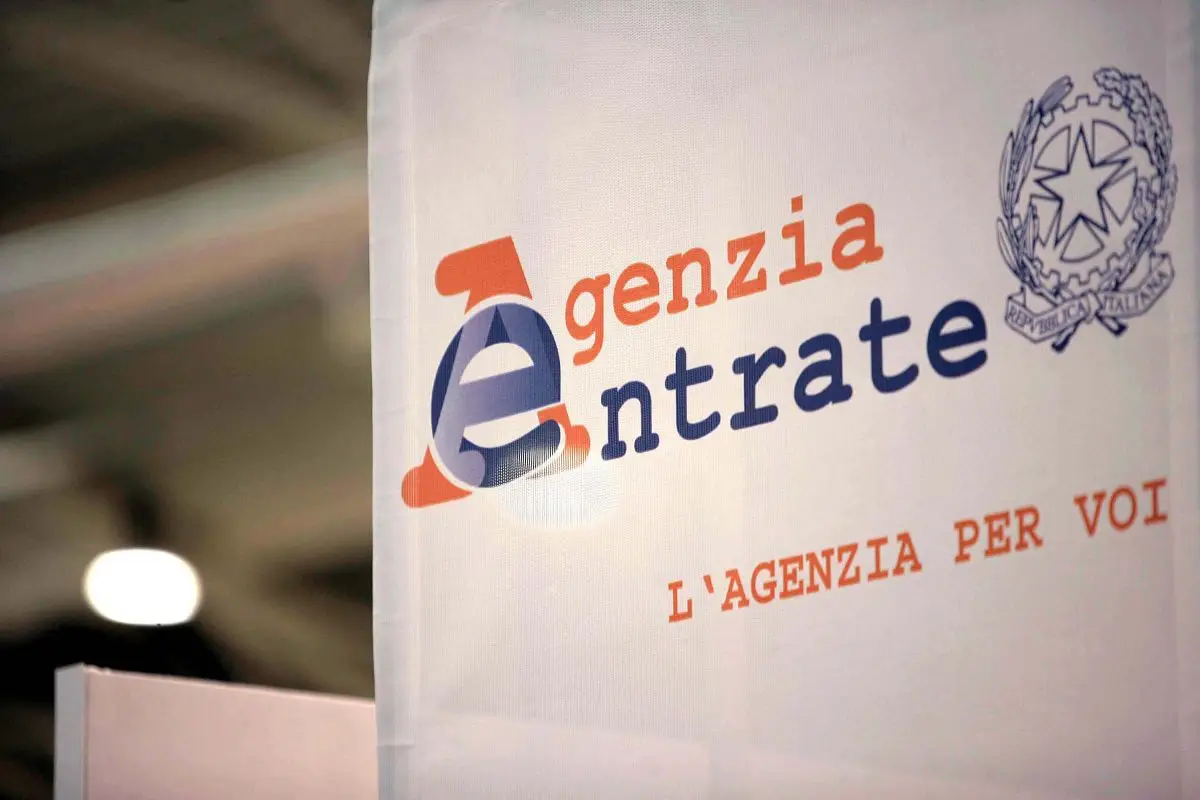La manovra fiscale del 2026 segna una significativa svolta nell’ambito della tassazione sulle persone fisiche in Italia, proponendo una nuova struttura delle aliquote Irpef e un cambiamento che inciderà concretamente sulle tasche di lavoratori, pensionati e autonomi. L’obiettivo principale di questa riforma è semplificare il sistema, offrire vantaggi ai redditi medio-bassi e ridistribuire il carico fiscale in modo più equo, pur mantenendo la sostenibilità dei conti pubblici.
Le nuove aliquote Irpef dal 2026
La Legge di Bilancio 2026 introduce una rimodulazione degli scaglioni Irpef, riducendo le aliquote e modificando l’incidenza fiscale sulle diverse fasce di reddito. Dal 1° gennaio, la struttura si presenta così:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 33% per i redditi tra 28.001 e 50.000 euro (scende dal precedente 35%);
- 43% per i redditi oltre 50.000 euro.
Questa nuova configurazione conferma la semplificazione già avviata nel 2025, passando definitivamente da quattro a tre scaglioni Irpef. Il taglio della seconda aliquota è il fulcro della manovra e punta ad alleggerire la pressione fiscale per il ceto medio. In particolare, la riduzione al 33% si applica a tutti i redditi fino a 200.000 euro; oltre questa soglia, il beneficio fiscale viene annullato da specifiche misure di sterilizzazione del risparmio d’imposta.
Chi risparmia e chi paga di più
L’impatto concreto della riforma varia a seconda dello scaglione di reddito:
- I contribuenti con redditi fino a 28.000 euro non registrano variazioni: continuano a essere tassati al 23% come negli anni precedenti.
- Coloro che dichiarano redditi tra 28.001 e 50.000 euro sono i principali beneficiari della riforma, con un taglio immediato dell’imposizione pari a 2 punti percentuali sull’aliquota marginale (dal 35% al 33%). Il risparmio massimo in termini assoluti si registra per chi dichiara almeno 50.000 euro annui, arrivando fino a 440 euro di beneficio fiscale annuo.
- I redditi superiori a 50.000 euro sono tassati al 43% sulla parte eccedente, ma fino a 200.000 euro possono ancora beneficiare della riduzione Irpef nella fascia precedente. Tuttavia, sono previste misure per sterilizzare il vantaggio sui redditi molto elevati, in modo da evitare effetti regressivi e limitare che il risparmio più elevato si concentri sui contribuenti più ricchi. Per chi supera i 200.000 euro l’anno, di fatto, la riduzione Irpef perde efficacia.
In estrema sintesi, nessuna categoria vede un aumento diretto delle aliquote: la legge si focalizza sul sostegno ai redditi medio-bassi e sulla neutralizzazione dei vantaggi per i redditi più alti. Tuttavia, le fasce elevate potrebbero vedere un incremento indiretto del carico fiscale per effetto della riduzione o eliminazione di alcuni meccanismi detrazionali che prima avvantaggiavano questi contribuenti.
Mini-guide agli effetti della riforma: calcoli e distribuzione dei benefici
Per comprendere meglio chi guadagna davvero e quanto, è utile osservare alcuni casi pratici:
- Chi guadagna 30.000 euro otterrà un risparmio annuo di circa 40 euro.
- Un reddito annuo di 35.000 euro godrà di un beneficio stimato in 140 euro.
- Il massimo vantaggio, come già riportato, si assesta sui 440 euro per chi percepisce almeno 50.000 euro.
La platea dei beneficiari diretti è costituita da oltre 13 milioni di contribuenti, circa un terzo del totale, con un costo stimato per lo Stato di circa 2,9 miliardi di euro nel 2026, destinato a salire negli anni successivi. È evidente quindi la volontà di intervenire in modo calibrato, premiando soprattutto chi si trova nelle fasce di reddito intermedie senza disperdere risorse su chi ha già una capacità contributiva molto elevata.
Ulteriori novità della Manovra 2026: detassazione e semplificazioni
La riforma delle aliquote Irpef è accompagnata da altre misure, sempre orientate alla riduzione e razionalizzazione della pressione fiscale:
- Detassazione di straordinari, festivi e lavoro notturno: per il 2026 sarà applicata una flat tax del 15% su queste voci per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 40.000 euro, in sostituzione dell’imposizione Irpef e delle addizionali locali.
- Incremento del tetto del “cinque per mille”: salirà da 525 milioni a 610 milioni di euro, ampliando così i fondi destinati agli enti del Terzo Settore, una misura particolarmente rilevante per il Terzo Settore italiano.
- Possibile estensione della flat tax al 15% per i lavoratori autonomi, con tetto incrementato potenzialmente fino a 100.000 euro di reddito annuo.
- Nuove sanatorie fiscali e semplificazioni per famiglie e imprese, con l’obiettivo di razionalizzare il sistema e promuovere l’adempimento spontaneo.
Oltre a questi cambiamenti, la manovra prevede aggiustamenti per evitare che la riduzione delle aliquote possa risultare penalizzante per la progressività dell’imposta, attraverso l’implementazione di meccanismi di sterilizzazione del risparmio d’imposta per le fasce più alte. In questo modo, lo Stato cerca di evitare un effetto regressivo e di tutelare la tenuta dei conti pubblici in un momento di elevata attenzione agli equilibri finanziari.
L’Irpef a confronto con gli scorsi anni: semplificazione e impatto sul sistema fiscale
Rispetto al passato, la svolta principale sta nella semplificazione della struttura degli scaglioni, che rende più chiaro e trasparente il calcolo dell’imposta e favorisce una più facile comprensione del funzionamento dell’Irpef sia per i contribuenti che per gli addetti ai lavori. Fino a pochi anni fa, il sistema prevedeva quattro – talvolta cinque – scaglioni, con una miriade di detrazioni, deduzioni e agevolazioni, spesso fonti di disparità di trattamento e complicazioni gestionali.
Con la nuova configurazione, l’Irpef diventa più simile ai moderni sistemi fiscali europei, abbandonando la complessità che ha sempre caratterizzato il modello italiano e puntando su una maggiore equità fiscale. In quest’ottica, la delimitazione del beneficio ai redditi fino a 200.000 euro e la sterilizzazione per i redditi superiori consente di mantenere l’impianto progressivo senza cedere a logiche di “regalo ai più ricchi”.
Infine, va ricordato che le modifiche alle aliquote Irpef rappresentano un tassello fondamentale delle strategie di consolidamento fiscale del Paese, nella prospettiva di coniugare crescita economica, coesione sociale e rispetto degli impegni europei.
La riforma fiscale del 2026 si configura quindi come un intervento articolato e con effetti di medio periodo, ponendo le basi per un sistema tributario più semplice, più giusto e più sostenibile, con benefici concentrati sulle fasce intermedie e azioni di riequilibrio per evitare aumenti nascosti della pressione sui contribuenti più abbienti.